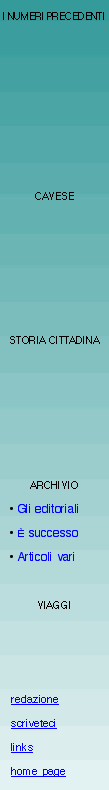
storia
Il trionfo della DC e il dualismo Abbro -
Romano
Nel 1943 Cava fu teatro di una violenta
battaglia tra le truppe tedesche e quelle anglo-americane.
Circa seicento cavesi persero la vita nelle azioni di
rappresaglia dei soldati di Hitler o durante i bombardamenti.
Gli alleati sbarcarono a Salerno la notte dell’8
settembre, poche ore dopo la notizia dell’armistizio,
diffusa dalla radio, e arrivarono in piazza San Francesco
all’alba del 9 settembre. La reazione dei tedeschi fu
durissima: occuparono Corso Umberto con i carri armati e
piazzarono le bocche da fuoco dell’artiglieria pesante
nei villaggi. La loro resistenza durò venti giorni. Gli
anglo-americani, aiutati da numerosi giovani cavesi, dovettero
conquistare la città metro per metro.
L’8 settembre ’43
Riccardo Romano ha un ricordo
personalissimo di quelle giornate drammatiche. A Cava, la sera
dell’8 settembre 1943, arrivò una camionetta di
militari inglesi, diretta da un colonnello. Ad aspettarli in
piazza San Francesco c’era un giovane cavese. Il
colonnello lo fece salire sulla camionetta e parlarono a lungo
in francese. Il giovane gli disse che potevano occupare
liberamente la città, perché i tedeschi erano
andati via. Gli alleati potevano avanzare verso Napoli, non
c’erano problemi. Quel giovane coraggioso era proprio
Riccardo Romano, e aveva 21 anni. Ricorda ancora quella
conversazione. Gli è rimasta stampata nella mente.
«Il colonnello - dice - rispose che non era possibile
occupare Cava, perché dovevano prima rafforzare il
fronte sul mare e aspettare i rifornimenti. Mi diede
appuntamento per il mattino successivo. L’indomani,
quando tornai in piazza San Francesco, trovai i tedeschi che
avevano occupato la zona e avevano piazzato alcuni cannoni nei
punti strategici. Cominciarono così i giorni del
combattimento, che durarono fino al 29 settembre».
La resistenza disorganizzata
A Cava non ci fu una vera e propria
resistenza contro i tedeschi. «Non eravamo organizzati -
spiega Romano. - La cosa fu così improvvisa che non si
pensò nemmeno di incontrarci e di organizzare una lotta.
Non avevamo armi, né esperienza, né un programma.
Perciò ci furono solo episodi isolati».
I giorni terribili dei bombardamenti
Furono giorni terribili per la
popolazione, che aveva trovato rifugio nei casolari di campagna
o all’Abbazia benedettina, dove furono ospitati
più di seimila cavesi. «Ricordo ancora i
bombardamenti e i camion degli americani che passavano giorno e
notte per le strade polverose di Cava», dice Amalia
Coppola Paolillo, che allora era una ragazza di 15 anni, con i
lunghi capelli corvini tirati all’indietro. Quando il 29
settembre i tedeschi abbandonarono la città, facendo
saltare in aria il ponte di San Francesco e il ponte sulla
ferrovia, all’altezza di villa Alba, la vita del borgo
lentamente riprese.
Il fronte di guerra si spostò a
Cassino, dove rimase fermo per alcuni mesi. La tempesta era
passata, ma si stentava a tornare alla normalità.
«C’era una grande confusione in quel periodo -
racconta Amalia Coppola - Circolavano per la città
soldati americani, neozelandesi, africani. Masse di profughi si
spostavano dal Nord verso il Sud e viceversa. Il Circolo
Sociale, tempio laico della borghesia cavese, fu
“profanato” dagli americani, che organizzarono
balli e fraternizzarono con il popolo. I soldati americani
avevano portato da casa dischi di jazz. C’era perfino chi
ballava il boogie woogie in mezzo alla strada. La mia famiglia
non aveva problemi economici, ma in giro c’era tanta
miseria: molti vivevano mangiando cachi e pane nero. Casa
nostra era aperta a tutti. C’era sempre un piatto di
minestra per chi ne aveva bisogno».
Dal C.L.N. rinasce la politica
La vita politica cittadina
ricominciò con la formazione della sezione locale del
Comitato di liberazione (Cln). Il padre di Amalia, Mario
Coppola, proveniente dalle fila di Giustizia e Libertà,
militava allora nel partito d’Azione. Poi, dopo lo
scioglimento del partito, confluì nel Pri di Ugo La
Malfa, insieme all’avvocato Ferruccio Falcone. Nato nel
1889, Mario Coppola aveva appreso il verbo mazziniano nel
collegio “Cicognini” di Prato, lo stesso dove
furono educati Gabriele D’Annunzio e Curzio Malaparte. Fu
uno dei fondatori della Giovine Italia a Cava.
Nel clima assolutamente monarchico del
tempo, le sue idee repubblicane erano considerate
rivoluzionarie. «Fu tanto fedele al suo ideale di
giustizia sociale, che regalò agli operai la fabbrica
tessile che avevamo a Molina di Vietri», ricorda Amalia.
Mario Coppola, tra l’altro, era un “33”, il
massimo grado della massoneria campana. Nelle logge dei primi
decenni del secolo, i massoni prepararono culturalmente
l’avvento della Repubblica. Durante il fascismo, per
queste sue idee, Coppola fu perseguitato dalle autorità
locali. Quando arrivava a Cava o a Salerno qualche pezzo grosso
del Regime, le forze dell’ordine rinchiudevano in carcere
tutti gli antifascisti. E tra questi c’era pure lui.
Sposato con una donna di origine tedesca, Ines Von Schoeder,
dopo la caduta del fascismo Coppola entrò a far parte
del comitato provinciale per l’epurazione. «Mio
padre però non aveva un carattere persecutorio, non era
vendicativo. Per questo perdonò i fascisti
cavesi», racconta Amalia. E così, anche chi aveva
rivestito la carica di segretario federale del Fascio, come
Santoro, Enzo Malinconico e Antonio Lupi, non ebbe alcun
problema con la giustizia. Nel 1954, anzi, uno di loro, Antonio
Lupi, fu candidato dal Msi alle elezioni provinciali, ma non
riuscì ad essere eletto.
La sezione del Partito Comunista nel 1943
a Cava non esisteva. C’era solo un gruppo universitario
comunista, del quale faceva parte anche il giovane Romano:
«Avevamo creato una sezione universitaria comunista. Ne
facevano parte Gino Cataldo, Erasmo Barbarulo, Giovanni
Martoccia, Salvatore Saturnino. Il primo volantino del Pci
cavese lo scrissi proprio io, nel 1943: il testo giustificava
il comunismo sulla base dell’ideologia di
Sant’Ambrogio. Fui anche convocato dal Field Security
Office, la polizia alleata, perché distribuivamo
materiale di propaganda comunista. Volevano sapere chi eravamo
e che cosa facevamo».
Al municipio, che era allora la sede del
Partito d’Azione, i comunisti cavesi costituirono un
fronte giovanile di azione repubblicana, con socialisti,
azionisti e repubblicani. «Eravamo un gruppo di giovani
che si batté poi per la Repubblica e per la Costituente
- dice il padre de]la sinistra cavese - L’obiettivo della
creazione di uno Stato nuovo era comune. Fu una stagione
esaltante perché si viveva di ideali. Discutevamo del
futuro dell’ltalia, di quale paese avremmo creato».
Nel clima febbrile della ricostruzione e
del ritorno alla libertà, un gruppo di professionisti,
di ferrovieri e di operai rifondò la sezione socialista
cittadina, intitolata a Carlo Pisacane. Nel 1946 fu eletto
segretario del Psi Renato Paolillo, il futuro marito di Amalia.
C’erano con lui l’avvocato Giovanni Pagliara, il
professore Enrico Albano, l’avvocato Erasmo Barbarulo,
l’avvocato Pasquale Panza, il professore Gian Battista
Martoccia. Ma l’anno dopo, con la scissione di Palazzo
Barberini e la fondazione del Psdi da parte di Saragat, i
Paolillo abbandonarono il Psi aderendo al nuovo partito,
perché contrari al patto di unità d’azione
con il Pci.
La sezione Gramsci del Pci fu fondata dal
gruppo universitario comunista. «Avevamo una sede in
Corso Umberto che io avevo preso in affitto prima ancora del 25
luglio, mascherandola come studio professionale - ricorda
Romano - Poi la sezione fu colpita dagli obici della marina
inglese, dopo lo sbarco. Noi la rinnovammo, la ristrutturammo.
Il primo segretario del Pci fu Gino Cataldo. Le prime battaglie
le facevamo con l’altoparlante, sul corso, contro i
rappresentanti dell’Uomo Qualunque che stavano in una
terrazza di fronte, vicino alla farmacia Carleo». Molti
degli esponenti dell’Uomo Qualunque passarono poi alla
Dc, quando ci fu la rottura dell’unità nazionale e
i socialisti e i comunisti furono cacciati dal governo.
«La Dc era allora un partito arretrato e conservatore -
dice il vecchio leader comunista. - tanto è vero che a
Cava non abbiamo avuto una partecipazione del Pci al governo
della città, tranne che nel primo periodo dei comitati
di liberazione, in cui si nominavano direttamente gli
amministratori».
1946: lotta per la Repubblica
Ma il 1946 fu anche l’anno della
battaglia per la Repubblica. La sostenevano gli azionisti, i
repubblicani, i socialisti e i comunisti. «Andavamo ad
affiggere i manifesti per la repubblica e a mettere gli
striscioni tra un balcone e l’altro del corso, fino alle
due di notte», ricorda Amalia Coppola. Gli avversari si
chiamavano Eugenio Abbro, Mario Pisapia, Renato Di Mauro,
Franco Gravagnuolo, il barone Luigi Formosa, i Lamberti e i
Baldi di S. Lucia. I monarchici erano fortissimi a Cava, come
in tutto il Sud Italia.
Anche l’avvocato Peppino Della
Monica, classe 1922, si schierò per la Repubblica.
«Il maresciallo De Cristofaro - ricorda - mi
convocò in caserma, insieme a Gaetano Lambiase, Mario
Coppola e Riccardo Romano. Fummo severamente ammoniti
perché sostenevamo la campagna per la Repubblica in
maniera troppo tumultuosa e aggressiva». Fu in quel
periodo che il giovane avvocato, alto un metro e ottantacinque,
con un fisico da giocatore di rugby e due occhi azzurri,
strinse amicizia con il leader dei comunisti cavesi.
«Organizzavamo comizi in tutta la città, dalla
mattina fino a sera tardi, con carrettini, camioncini,
microfoni improvvisati collegati alle batterie delle
automobili».
“Viva il Reo”
Ricorda Riccardo Romano: « La lotta
per la Repubblica fu particolarmente aspra. Ci furono anche
pericoli di scontro. Le manifestazioni repubblicane furono
abbastanza imponenti. Feci il rappresentante di lista a San
Pietro, che era una delle zone più conservatrici di
Cava. Il presidente di seggio era l’avvocato Goffredo
Sorrentino, democristiano, il quale durante lo scrutinio ogni
tanto mi guardava, preannunciando un voto per la Repubblica che
fu in estrema minoranza in quel seggio. Durante la notte
antecedente al referendum andammo in giro con secchi di calce.
I monarchici scrivevano “Viva il re” e noi
aggiungevamo una “o”, cioè “Viva il
reo”. Scrivevamo per terra, per non sporcare i muri. Ci
ritrovammo alle 6 del mattino che nessuno di noi aveva dormito
e dovemmo smettere perché non era più possibile
continuare. E ci rendemmo conto che non si capiva più
niente di quello che avevamo scritto. Gli slogan lungo il corso
di Cava erano sovrapposti. Gli avversari della Repubblica erano
Abbro, i mediatori di bestiame, alcuni commercianti. Insomma,
tutte le forze della conservazione che allora costituivano la
classe dirigente».
Una valanga di voti alla DC
Un grosso risultato, al di là delle
aspettative, lo ebbe anche la Dc. Ricorda Amalia Coppola:
«Seguii le elezioni alla radio, insieme a tanta altra
gente. Il voto era doppio: per la Monarchia o la Repubblica e
per la Costituente. I voti della Dc furono una valanga: una
vera sorpresa per noi. Comunque, dopo la vittoria della
Repubblica, mio padre organizzò cortei e fuochi
d’artificio. Al ballo in piazza indossai un vestito rosso
fiamma. Danzai insieme agli operai e alla gente del popolo:
allora era considerato quasi uno scandalo».
La condizione degli operai cavesi
La condizione degli operai cavesi nel
dopoguerra era disastrosa. Riccardo Romano allora era
segretario della Camera del lavoro. E fece venire a Cava
Pesenti, che era ministro comunista delle finanze.
«C’era la crisi della Manifattura tabacchi -
racconta Romano - Riuscimmo a far ottenere agli operai una
razione mensile di sigari che poi essi stessi vendevano per
integrare la bassa retribuzione».
C’era molto lavoro nero in provincia
di Salerno e gli operai cavesi che andavano a lavorare nelle
altre città erano guardati con sospetto, perché
spesso erano crumiri. «Si trattava di piccoli contadini
che andavano a lavorare come muratori per integrare
l’utile della terra - spiega l’ex senatore
comunista - Per questo non partecipavano agli scioperi».
Era una tradizione della vita sociale di Cava che l’uomo
andasse a lavorare fuori come muratore o come manovale.
«Le donne, invece, lavoravano prima al telaio, alla fine
dell’Ottocento, e poi nei campi di tabacco per integrare
il reddito familiare. Quelli che vivevano meglio erano coloro
che avevano questa forma di integrazione grazie al lavoro della
donna». Anche per questo Cava negli anni ‘50 era
più ricca delle altre città della provincia.
«La nostra città è stata sempre
privilegiata rispetto alle altre, perché ha pesato molto
il lavoro delle donne. Le industrie erano industrie femminili:
la Manifattura e l’Agenzia Tabacchi, la Manifattura
tessile di Passiano, la Manifattura Bisogno. Gruppi operai
maschili c’erano solo al pastificio Ferro e alla
tipografia Di Mauro. La maggior parte della base operaia era
formata da donne. Gli uomini, se non andavano a lavorare fuori,
o erano artigiani oppure piccoli commercianti» Questa
particolare composizione del ceto operaio determinava anche
molti consensi al Pci da parte delle donne. «Tanto
è vero - dice Romano - che abbiamo eletto diverse donne
al consiglio comunale».
C’era però un rischio: quello
di una frattura tra le donne operaie comuniste e i
contadini-muratori di destra o democristiani. Ma il Pci
cercò di evitarla. «Piano piano lavorammo sugli
edili e riuscimmo a creare un gruppo omogeneo e responsabile -
dice Romano - ma ci vollero molti anni per portare il settore
edile alla coscienza sindacale di classe. Gli operai edili
erano assunti direttamente dal padrone e non venivano pagati
con le paghe sindacali».
Ricordo del sindaco Avigliano
«La prima regola per la classe
dirigente del dopoguerra era il rigore morale». Peppino
Della Monica ha un ricordo bellissimo della prima
amministrazione della città, guidata dal sindaco Gaetano
Avigliano, democristiano. «A quei tempi non c’era
clientelismo, né tangenti», dice. I nomi di quella
coalizione del 1946 tra Dc, Pri, Psi, Lista Combattenti e Uomo
Qualunque, li ha come scolpiti nella mente: i democristiani
Eugenio Gravagnuolo, vicesindaco, Mario Prisco (professore),
Maria Casaburi (professoressa), Federico De Filippis (dottore),
Benedetto Accarino (avvocato), il “combattente”
Salvatore Apicella (capitano dell’Esercito), il
repubblicano Francesco Rossi (ragioniere), i socialisti Antonio
Biondi (dipendente delle Ferrovie) e Angelo Vella (oggi alto
magistrato).
Nelle elezioni amministrative del 1947 il
Pci prese solo 800 voti. Furono eletti consiglieri comunali
Riccardo Romano e due operaie della Manifattura Tabacchi, Maria
Benincasa e Filomena Placido. «Allora noi avevamo
l’obiettivo di conquistare le fabbriche di Cava - ricorda
il leader del Pci - e difatti avevamo iscritti alla Manifattura
e allo stabilimento tessile di Siani a Passiano, che negli anni
successivi ci diede un altro consigliere, Maria Matonti, una
bravissima compagna, energica e combattiva».
Della Monica si candidò per il Pri,
risultò eletto e divenne assessore all’anagrafe e
allo stato civile della giunta Avigliano. «Ho una memoria
dolcissima di Avigliano - dice - per il tatto, il garbo, la
pacatezza dei modi, la sobrietà dei costumi,
l’intelligenza. E’ stato un grande sindaco».
Un episodio in particolare Della Monica ricorda, per
sottolineare il rigore morale di quegli anni. «Il comune
fu invitato a Roma, a partecipare alle onoranze tributate a
Mamma Lucia dall’Associazione delle vittime della guerra.
Fui delegato io ad accompagnarla e a rappresentare il
Municipio. Ero lieto di essere stato scelto, ma purtroppo ero
senza soldi e non sapevo come fare. Fui chiamato
all’economato dall’impiegato Pierino Durante che mi
diede 5 mila lire. Poi fui convocato da Eugenio Gravagnuolo,
assessore alle finanze: “Mi raccomando - disse questo
è un fondo solo per le spese necessarie. Questi soldi si
chiamano ritorno”. Quando tornai, riportai indietro 4.720
lire. Altri tempi, purtroppo. Allora la politica era una
gestione sentimentale della cosa pubblica, lontana dagli
intrallazzi e dagli interessi di parte».
L’arrivo di Abbro…
In quegli anni il Pci aveva ottimi
rapporti sia con i socialisti (il preside Grimaldi, Gaetano
Panza, Alfonso Rispoli, l’ingegnere Accarino, Gaetano
Lambiase), sia con i repubblicani, che però facevano
parte dell’amministrazione (Peppino Della Monica, il
ragioniere Rossi, Scandone, Mario Coppola). L’avversario
comune era la Dc. «La Democrazia cristiana - dice Romano
- quando si costituì come partito, era formata da un
gruppo di vecchi galantuomini che però si scontrarono
subito con le forze di nuova immissione che erano reazionarie.
I primissimi democristiani furono l’avvocato Santacroce,
Petrone e il professore Raffaele Baldi, tutti e tre
antifascisti. Però furono subito fatti fuori dal gruppo
dell’Uomo Qualunque, che rovesciò questo nucleo
antifascista e portò la Dc su posizioni conservatrici.
Avigliano faceva parte di questo gruppo, cioè dei vecchi
fascisti che occuparono la Dc. Era un uomo onesto, corretto nei
rapporti politici, ma politicamente molto arretrato,
conservatore». Questo gruppo piuttosto moderato fu
sopraffatto in seguito dal gruppo monarchico di Abbro.
«Il nuovo leader della Dc distrusse completamente il
vecchio partito democristiano, impose una linea populista alla
Dc e riuscì a conquistare la città con
l’appoggio di quelli che si erano arricchiti con la
guerra». Ma intanto anche il Pci si era rafforzato.
Della Monica restò assessore fino alla
metà degli anni Cinquanta, quando cominciò a
brillare l’astro nascente di Eugenio Abbro. Il professore
di educazione fisica di fede monarchica, dopo aver vinto le
elezioni, riuscì a conquistare la Dc e a diventarne il
leader. «Quando si ebbe la contaminazione tra Dc e
monarchici - dice Della Monica - il partito scudocrociato
cambiò profondamente. Qualche democristiano si oppose,
come Daniele Caiazza. Ma era troppo solo. La contaminazione
peggiorò la Dc. Quando arrivò Abbro, finì
il partito di Avigliano che era rispettabile, non dava adito a
critiche negative sotto il profilo morale ed era apprezzato da
tutti per la sua rettitudine amministrativa e per l’amore
nelle cose cittadine». Della Monica non partecipò
alle amministrazioni monarchiche guidate dal barone Formosa e
poi da Abbro. Né entrò nelle giunte a monocolore
democristiano, quando il passaggio di Abbro nella Dc fu
consumato. «Ho collaborato solo con la Dc buona, quella
di Avigliano. Con la Dc di dopo non ho mai voluto averci a che
fare». E infatti, dopo la lunga parentesi in giunta,
1947-1954, il Pri passò all’opposizione, insieme
al Psi del preside Grimaldi e al Pci di Riccardo Romano.
1954: un voto che fece scalpore
Nel 1954, quando Abbro si dimise dal
consiglio provinciale per fare il sindaco di Cava al posto di
Formosa, Riccardo Romano fu candidato dalla sinistra unita
(Pci, Psi, Pri) alle elezioni provinciali e vinse il collegio
con il 50,7 per cento dei voti. «Fu una vittoria
clamorosa, in pieno scelbismo, contrastata violentemente dalla
Dc, che diceva che io avevo le mani sporche di sangue
perché ero comunista - ricorda Romano - La nostra
vittoria ebbe rilevanza nazionale. In pieno scelbismo, in una
città meridionale, riuscire a sconfiggere insieme il
candidato della Dc, Avigliano, e quello dei fascisti, il
professore Lupi, fu clamoroso. Difatti l’Unità
pubblicò la notizia in prima pagina. Giorgio Amendola
esaltò in cronaca meridionale la vittoria unitaria.
Questa vittoria fu possibile anche perché io nel 1952
ero stato cacciato dalla scuola di Agropoli dopo essermi
scontrato con un prete. Costui fece intervenire il Vaticano e
il Ministero dell’interno per farmi trasferire a Cava,
perché ero comunista e insegnavo con criteri
democratici. Andai a insegnare alla scuola media a piazza San
Francesco».
L’affermazione della sinistra fu
determinata anche dal voto contadino. Un anno prima, una grave
malattia, la peronospera, aveva distrutto tutto il tabacco. I
contadini erano disperati, perché avevano perso tutto il
raccolto di un anno e la situazione economica era tragica.
Romano organizzò i contadini, operando così
quella fusione tra lavoro contadino e lavoro operaio che fino
ad allora era stata impossibile e superando la frattura che
c’era.
Cominciò a crescere il Pci
La vittoria del ‘54 segnò
l’inizio dello sviluppo del Pci. «Nell’ambito
del partito comunista era avvenuto un ricambio. Parte del
vecchio gruppo universitario gradualmente passò ai
socialdemocratici e io rimasi solo a condurre la lotta
politica. La base del partito era costituita da povera gente,
non il sottoproletariato, ma il reale proletariato cavese.
Avevamo dieci sezioni del partito a Cava. Il mio slogan era
“Ogni campanile una sezione del Pci”. Avevamo
sezioni a Rotolo, Marini, Licurti, Annunziata, Dupino, S.
Cesareo, Passiano, S.Lucia, Pregiato, S. Arcangelo e Cava
centro. C’era anche qualche contadino. Ma i contadini
davano la loro partecipazione con le lotte, non con
l’adesione. Le sezioni erano una specie di circoli operai
che organizzavano riunioni. Dopo il ‘54 ci fu
l’esplosione. Arrivarono consensi anche dal ceto medio
perché si era formata la coscienza del partito nuovo,
della via nazionale al socialismo. Però la borghesia non
aderiva. Quelli del ceto medio non si scoprivano, ma votavano
per noi».
La partecipazione ai comizi del Pci in
piazza Mazzini, in piazza Duomo, nelle frazioni, era di massa.
«I nostri comizi - ricorda Romano - erano sempre
più frequenti, perché erano basati sulla
necessità di uno sviluppo democratico locale e
nazionale. Erano fortemente ancorati alla realtà locale.
Erano una specie di scuola di partito fatta all’aperto
nel confronto con le masse». I segretari del partito
furono allora Arturo Di Gilio e Vincenzo Vitale. Nel gruppo
dirigente c’erano Egidio Muscariello, Renato Adinolfi,
Raffaele Palazzo a S. Arcangelo, Raffaele Lambiase e Lamberti a
S. Lucia. «Non c’erano molti giovani - sottolinea
l’ex senatore comunista - perché avevano la
preoccupazione della raccomandazione per il posto di lavoro. I
comunisti erano discriminati. E quindi il peso
dell’organizzazione era tutto sulle mie spalle. Non
passava un giorno che io non avessi una riunione in una casa di
campagna per spiegare i nostri obiettivi, che cosa volevamo
fare. La base operaia allora era molto interessata alla
politica, non come oggi».
Il problema della disoccupazione
Sul finire degli anni ‘50 la
disoccupazione era un problema molto grave a Cava. Se ne
occupò la Camera del lavoro. Fu un periodo di grossi
conflitti sociali. «Una volta i disoccupati comunisti
furono anche aggrediti dalla celere di Scelba che con le
camionette inseguì i manifestanti che chiedevano il
lavoro anche sotto i portici. Questo scontro con la celere fece
impressione anche sui commercianti di Cava, che condannarono
l’operato della polizia», ricorda Riccardo. Un
altro scontro violento con la polizia ci fu in occasione dello
sciopero del latte. Le donne contadine andarono a rovesciare le
secchie del latte dei crumiri, a S. Arcangelo specialmente.
«Erano le donne a muoversi, lasciando da parte gli
uomini, perché c’era la convinzione che loro non
potessero essere arrestate. Quindi le donne erano le più
attive nella lotta».
Il Pci di Cava diventò il
più forte della provincia. «Non fu merito solo
della mia azione intensa e permanente, ma anche della nostra
strategia. Indicammo ai cavesi la via giusta, puntando su
obiettivi concreti: il prezzo del latte, il rispetto della
legge sui fitti dei fondi rustici, che ha consentito a molti
contadini di diventare proprietari della terra che lavoravano,
le lotte per l’occupazione, la presenza organica nelle
frazioni. La nostra forza è stata quella di proporre
obiettivi alternativi concreti rispetto alla politica della
Dc». Ha contato anche l’appoggio della classe
media. «Il benessere degli operai era anche il benessere
dei commercianti e della classe media - spiega il vecchio
leader. - Se gli operai trovavano un lavoro nelle fabbriche,
anche i commercianti guadagnavano di più. Perciò
tutte le lotte democratiche nella campagne e nelle fabbriche
trovarono come alleati naturali i commercianti che vedevano
nelle classi proletarie innanzitutto dei consumatori.
L’ambiente sociale di Cava era particolarmente adatto per
realizzare il collegamento tra ceti medi e lavoratori».
Il trionfo della classe intermedia
Il periodo aureo del Circolo Sociale si
stava esaurendo. Era finita un’epoca, l’epoca dei
balli della Taverna Verde, dei suicidi per lavare l’onta
della non ammissione al Circolo, dei titoli nobiliari. Si stava
affermando a Cava una nuova borghesia, che non si riconosceva
più nel Circolo Sociale.
Fu uno scandalo ad accelerare la fine del
Circolo. In una sola serata, uno dei soci perse ai tavoli da
gioco la somma stratosferica di cinquanta milioni di lire. Era
il 1960. Il Club sportivo Tennis, dotato di due campi di gioco
e di un bungalow che fungeva da spogliatoio, alla fine degli
anni ‘50 era stato trasformato in circolo
dall’ingegnere Casillo, che costruì lo stabile
attuale. Tra il Sociale e il Tennis nacque subito una forte
competizione. Competizione che vide protagonisti da una parte
lo stesso ingegnere Casillo e dall’altra
l’ingegnere Gaetano Accarino, del Sociale. Ma il vecchio
Circolo era ormai in declino. Il colpo di grazia glielo diede
proprio lo scandalo suscitato da quella grossa perdita al gioco
che coinvolse un po’ tutto il sodalizio. L’unica
soluzione per uscirne era chiudere il Sociale e vendere la sede
di Corso Umberto. Con la mediazione di Mario Amabile (socio del
Sociale, proprietario del Credito Commerciale Tirreno), tutti
gli iscritti al Sociale, con la sola eccezione del professore
Giovanni Violante, si convinsero ad accettare la fusione con il
Tennis Club. La sede di Corso Umberto fu venduta,
dall’ingegnere Ninì Capano, alla Banca Cavese e di
Maiori, successivamente acquistata dal Monte dei Paschi di
Siena.
Un nuovo circolo esclusivo
Così il Tennis Club, che era
presieduto dal marchese Rende, divenne il nuovo circolo
esclusivo della città, aprendosi però anche alle
classi sociali emergenti. La nobiltà e la borghesia
romana, napoletana e salernitana vennero in massa a Cava, a
giocare a chemin e a baccarà. «Sotto la presidenza
dell’avvocato Mario Parrilli il Tennis raggiunse il suo
massimo splendore», dice Amalia Coppola, che allora era
la madrina del Club. Furono costruiti anche la piscina
olimpionica e un altro campo da tennis. Commettendo però
un grande errore. Per edificare la piscina si eliminò
uno dei due campi da tennis esistenti, omologati per i tornei
internazionali. Cava perse all’improvviso la
possibilità di far parte del circuito nazionale e di
vedere all’opera campioni come Pietrangeli ed altri: il
campetto aggiunto nella villa comunale era adatto più
agli allenamenti che ai tornei.
Borghesia cavese illuminata
La figura di Riccardo Romano
affascinò anche l’alta borghesia. «Vedevano
in noi la contrapposizione al plebeismo di Abbro - sostiene
Romano. - Egli ha puntato sui ricchi strati commerciali e di
intermediazione, i contadini ricchi, i commercianti più
retrivi, i mediatori di bestiame. Gente come Mario Pisapia e
Renato Di Marino. Il suo era l’esercito della Santa Fede.
La borghesia cavese non si vedeva rappresentata da lui».
Per questo, nel segreto dell’urna, metteva la croce sulla
falce e martello. «Io ho sempre esaltato l’azione
politico-sociale della borghesia cavese che sin
dall’Ottocento è stata la più aperta
rispetto ai problemi della città. Cava è
l’unica città della provincia che avesse un
ospedale, una biblioteca, una casa di riposo per gli anziani,
case di accoglienza per gli orfani, il teatro comunale. Basti
pensare che Leopoldo Siani, che aveva costruito
l’industria tessile a Passiano, aveva aperto anche
l’asilo per i figli delle operaie, al fianco della
fabbrica, con una mentalità da industriale inglese e non
da bovaro meridionale italiano. La borghesia aveva fatto di
Cava una città diversa dalle altre. A me sembrava che il
Pci dovesse essere il vero continuatore di questa azione
illuministica che si era realizzata a Cava. Da una parte
c’era la politica plebea di Abbro: la gente era legata a
lui sulla base di favori e di clientele. Dall’altra
c’eravamo noi, che abbiamo rivalutato il proletariato e
abbiamo saldato le lotte dei contadini e degli operai con le
rivendicazioni della borghesia illuminata».
Si avvicinarono al Pci il dottore Mario
Esposito, l’avvocato Peppino Della Monica, Giannino
Violante, professore di ginnastica, Mario Pisapia, ex
monarchico, alcuni commercianti, l’ avvocato Pagliara, il
marchese Andrea Genoino. Una grande invenzione politica di
Romano furono gli indipendenti. «Il Pci aveva un seguito
enorme nel proletariato, ma pochi elementi capaci di essere
rappresentativi nelle istituzioni - spiega il vecchio leader -
Quindi aveva un bisogno disperato di trovare chi rappresentasse
questo proletariato. L’allargamento della base sociale fu
quasi una necessità di sopravvivenza del Pci. Io poi non
ero un uomo di partito chiuso, e difatti non sono mai stato un
funzionario».
Nel 1962 ci fu l’esperimento della
lista di concentrazione democratica, che aveva come simbolo due
mani unite. «Però - ricorda Romano - i
democristiani ci contestarono questo simbolo che era stato
presentato non so da chi a livello nazionale e lo dovemmo
cambiare all’ultimo momento con una ruota dentata».
La lista unitaria della sinistra ebbe un grande successo e
prese 15 consiglieri comunali. «Facemmo eleggere non solo
comunisti precisa l’ex senatore - Non eravamo chiusi o
settari. I candidati erano in ordine alfabetico, anche io.
Riuscimmo ad accontentare sia i socialisti che i repubblicani e
gli indipendenti, senza settarismi e con il pieno convincimento
della necessità di un’azione unitaria per lo
sviluppo della città e per contrastare la politica di
Abbro».
Al Senato il voto era per
“Riccarduccio”
Arriviamo al 1963. Candidato dal Pri alla
Camera dei deputati, Peppino Della Monica prese più di
mille voti. Girando per le case dei cavesi poté toccare
con mano lo “strano amore” della borghesia per
Riccardo Romano. «Quando invitavo le famiglie borghesi di
Cava a votarmi alla Camera, si scusavano e dicevano che
dovevano votare per il candidato liberale che li rappresentava
meglio di me. Quando però chiedevo se avrebbero votato
anche al Senato per il candidato liberale, dicevano che no, non
era possibile, il loro voto era per Riccarduccio».
Ma chi era Riccardo Romano? Il ritratto di
Della Monica è preciso: «Era un combattente
purissimo, un gladiatore della politica, che non esitava ad
esporsi per tutelare la classe operaia. E aveva la splendida
qualità del disinteresse. Mio zio a novanta anni veniva
da Napoli a Cava, quando c’erano le elezioni, solo per
votare per lui. Politicamente ispirava molta simpatia anche
alla borghesia. La borghesia alle elezioni politiche preferiva
votare contro se stessa, per il proletariato, perché
sapeva che Romano era un uomo giusto, che pensava prima di
tutto al bene della comunità. La sua bella parola
conquistava la folla. No, non era un oratore, non aveva
un’oratoria aulica. Ma i suoi discorsi stringati erano
piacevolissimi».
Romano veniva dalle fila del Seminario di
Cava. Per entrarvi aveva avuto l’appoggio del Vescovo.
«Ecco perché la Chiesa gridava al tradimento. Non
poteva sopportare l’affronto. Ma quanto più la
Chiesa attaccava Romano, tanto più la borghesia lo aveva
in simpatia. Riccardo era invitato anche alle manifestazioni di
una certa mondanità», dice Della Monica.
E così nel 1963 Riccardo Romano
diventa senatore. Sarà riconfermato in questa carica
fino al 1972.
Una donna in Consiglio Comunale
Alle amministrative del 1966 il simbolo
del Pri non si presentò. «Il Pri non poteva
svanire nel nulla. Perciò accettai di candidarmi nella
Dc come indipendente, dopo che la segreteria provinciale del
partito mi diede il suo placet. Ma subito dopo le elezioni,
alla prima seduta del consiglio comunale feci dichiarazione di
appartenenza al gruppo repubblicano», ricorda Amalia
Coppola. La sua candidatura riscosse un successo clamoroso:
quasi mille e trecento voti. Ma provocò anche molte
polemiche. Durante la campagna elettorale, Peppino Della
Monica, intervenendo a un comizio della Dc al cinema Metropol,
apostrofò pesantemente Amalia Coppola, accusandola di
aver tradito la memoria del padre. «Avemmo un alterco -
racconta la Coppola. - D’altronde, ho dimostrato con i
fatti di essere rimasta fedele ai miei ideali». Infatti,
negli anni successivi, Amalia, insieme a Mario Scotto,
rifondò la sezione del Pri. Allora la base del partito
era costituita da professionisti e esponenti del ceto medio,
come Emilio Scandone, il ragioniere Rossi, il professore
Vitale, Antonio Avella, il sarto Argentino.
Nel ‘68 la base del partito si
arricchì. I figli di coloro che avevano sostenuto
dall’esterno il Pci entrarono nel partito. «Per me
fu un elemento di liberazione - dice Romano - Non ce la facevo
più fisicamente, avvertivo il bisogno del
rinnovamento». Entrarono allora Achille Mughini e,
più tardi, Raffaele Fiorillo.
“Così Abbro ha distrutto la
Dc”
Il giudizio di Romano sul suo avversario
storico è durissimo. «Abbro ha distrutto la Dc che
nel dopoguerra era un partito democratico e ha creato un
partito che non poteva fare a meno di lui, facendo allontanare
uno dopo l’altro i vecchi galantuomini. Gli Avigliano e
gli altri non potevano competere con lui sul terreno del
plebeismo».
Eppure Abbro si è sempre vantato di
aver fatto di Cava una Piccola Svizzera. Anche questa
affermazione è contestata da Romano: «La nostra
città - dice - non è diventata quella che
è per opera di Abbro. E’ l’azione della
borghesia illuminata dell’Ottocento che l’ha fatta
sviluppare». E le case popolari, le strutture sportive,
le opere pubbliche costruite sotto il sindacato di Abbro?
«C’era già una base fortissima - spiega il
vecchio leader. - Basti pensare che l’ente di assistenza
era il più ricco della provincia. Oltretutto lui doveva
far fronte anche alla nostra azione politica, che non gli dava
tregua. Comunque, se fosse stato per Abbro, avremmo avuto 90
mila abitanti, come prevedeva il piano regolatore. Lui è
stato molto aperto nei confronti degli abusi edilizi. Quando ha
potuto favorire gli speculatori, l’ha fatto. A via
Vittorio Veneto, per esempio, la strada è così
stretta e non ha marciapiedi, perché lui ha consentito
l’occupazione del suolo fin dove era possibile».
Secondo Romano Cava si sarebbe salvata
dallo sviluppo edilizio caotico delle altre città per
due motivi: il piano regolatore approvato all’epoca di
Gaetano Avigliano e l’opposizione del Pci e del Psi.
«La città - dice - è stata salvata da quel
piano regolatore, non da Abbro, che se avesse potuto avrebbe
fatto tutte le deroghe possibili. A un certo punto aveva avuto
addirittura la brillante idea di creare un grattacielo in
piazza Roma, dove c’è il cinema Alambra».
Mario Avagliano




